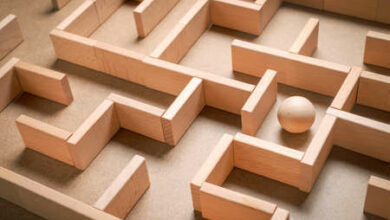“Tornare alla normalità” è ora la vera Emergenza

All’inizio era come una brezza di primavera, echi lontani da mondi lontani. Con il passare dei giorni però le notizie, dapprima rade e concise, acquisivano maggiore corposità occupando con ritmo frenetico spazi sempre più ampi.
I “super-esperti” dapprima timidamente e poi con piglio baldanzoso bucavano lo schermo affermando tutto ed il contrario di tutto; si tratta solo di una influenza un po’ più impegnativa ingigantita da una montatura giornalistica che presto si sgonfierà da sola, dicevano alcuni. É una catastrofe incombente, rispondevano altri, prepariamoci al peggio!
In ospedale dapprima con pudore, quasi a vergognarsene, alcuni incominciavano ad indossare la mascherina chirurgica in ambulatorio e non stringevano più la mano sentendo però sempre la necessità di giustificare questa precauzione con un sorrisetto di circostanza a chi derideva e a chi ammoniva: “Guarda che così generi panico immotivato”.
All’improvviso però le parole “Paziente 0”, “Zona rossa” e lock down in batter d’occhio cambiarono radicalmente la nostra vita, stravolgendo il nostro quotidiano in modo inaspettato ed imprevedibile e la prima domenica di marzo all’Umberto I di Enna iniziavano freneticamente i preparativi per ospitare i malati COVID. Non dieci o venti posti, ma addirittura 100 per far fronte all’emergenza così come prospettata nelle stime dell’assessorato. In quel momento tutti ci siamo resi conto che il coronavirus si era trasformato da argomento da chiacchiere da bar ad una realtà concreta pronta ad impadronirsi delle nostre vite. Ed in fretta ed in furia, così come si scavano trincee e si alzano reticolati prima della battaglia si apriva il reparto COVID1 e chi tra noi supportava i colleghi delle malattie infettive durante i turni notturni sentiva la marea montante dei ricoveri. Telefonate da pronti soccorsi vicini e lontani che cercavano disperatamente un posto letto, il cigolio delle barelle che accompagnavano i Pazienti dalla accettazione al reparto, i primi morti.
Infine, il 26 di marzo arriva la telefonata della Direzione Sanitaria che ti chiede di far parte dell’equipe del COVID2 a partire dall’indomani. Altri trenta posti, un’altra trincea per arginare il male dilagante. Reparto aperto e riempito in meno di 24 ore e gestito da tre oculisti, due dermatologi e due cardiologi e con solo il Primario Mauro Sapienza con esperienza come infettivologo ed internista. Un gruppo di giovani infermieri ricchi di entusiasmo ma alle prime armi guidati da un Capo Sala di provata competenza.
Sulla carta una armata Brancaleone; eppure per una strana alchimia che ha mescolato voglia di fare, orgoglio professionale e spirito di corpo tutto ha preso funzionare perfettamente. All’improvviso attraverso il fonendoscopio i polmoni cominciavano a parlarti sempre più chiaramente, le tac polmonari non erano più oscuri immagini al computer. Imparavi ad adoperare farmaci di cui non avevi mai sentito parlare prima. E si passava le notti in chat a scambiarsi articoli e note AIFA e a discutere di una malattia che nessuno veramente conosceva. Al centro di tutto Mauro il primo ad entrare e l’ultimo ad uscire a sera inoltrata. Un medico dalla grande esperienza con quella simpatia umana condita dalla verve di Catanese verace. E finalmente dopo Pasqua abbiamo tutti percepiti che la marea rientrava, nessun nuovo ricovero mentre le dimissioni erano sempre più numerose.
Ora che l’epidemia si sta spegnendo (o perlomeno così pare) possiamo dire di avere tratto da questo breve ed intenso periodo una esperienza umana e professionale che ci accompagnerà per sempre e dalla quale dovremmo trarre spunto per affrontare la nuova emergenza che ci aspetta e che si chiama “ritorno alla normalità” ovvero dell’impegno che tutti dobbiamo spendere per riappropriarci delle nostre vite. Una sfida a cui nessuno può sottrarsi.
Il primo dilemma che ci si presenta è quello dei porcospini di Schopenhauer: troppo vicini si pungono, troppo distanti non si riscaldano. Così ora se non prendiamo nessuna precauzione facciamo ripartire l’infezione, se ci facciamo prendere dalla paura eccessiva del contagio blocchiamo tutto. Come sempre la cosa più difficile è trovare la via di mezzo.
Questo vale soprattutto nella Sanità, la pandemia ha avuto la capacità di cristallizzare, trasferendo in un limbo, la quotidianità della malattia; quasi come se la gente non si ammalasse più. Ma così non è stato: parti, fratture, ictus ed addomi acuti hanno continuato a venire fuori. Tanto per citare le urgenze più frequenti. Per non parlare di tutti quelli che dopo lunghe attese si sono visti disdire appuntamenti per visite, indagini strumentali ed interventi programmati da lungo tempo e rimandate non si sa a quando. Pazienti cronici che necessitano di controlli regolari (come gli oncologici o i cardiopatici). A tutti questo arretrato occorre dare delle risposte in tempi accettabili senza allungare le liste di attesa, già di tutto rispetto in tempi normali.
Non ci sono cure miracolose o rimedi magici. Magari sarebbe utile trarre esperienza da quanto accaduto e usare in modo più incisivo la telemedicina per controllare i malati a distanza, con minore aggravio di tempo e costi. Pensiamo ai malati cronici, o alle consulenze specialistiche che possono essere erogate tra i vari presidi eliminando quando possibile la necessità di spostare il malato.
Certo c’è anche la possibilità di erogare le prestazioni nei pomeriggi e nei festivi. Ma per fare questo occorre disporre delle adeguate risorse umane e materiali, oltre che delle disponibilità finanziarie per pagare il plus lavoro.
E secondo me questo passa innanzitutto da una riorganizzazione in termini provinciali della nostra sanità, e vorrei soffermarmi sul termine provinciale, ovvero capace di dare a tutti le stesse opportunità di ricevere soddisfacenti cure. Sia agli abitanti di piccole comunità montane sia a chi vive nelle città più grandi.
E questa precisazione va fatta perché in questo particolare momento storico, così come peraltro in passato, si è verificato un fenomeno strano e particolare: nella stampa locale sono apparsi articoli che con moti arguti e articolate argomentazione affermavano un preciso e curioso assioma: la linea di confine che separa i vari comuni sede di ospedali, magicamente individua e caratterizza i comportamenti degli operatori sanitari. Di qua della linea sono tutti bravi e di là invece solo scansafatiche ed opportunisti. Al di qua della linea investimenti e strutture da mozzare il fiato a disposizione della comodità di comunità che vengono servite e riverite e al di là strutture fatiscenti che vengono fatte morire di inedia a scapito degli operosi e sfortunati cittadini di comuni vessati e lasciati al proprio destino. Guelfi e Ghibellini che in una logica di campanile lasciano poco spazio a ragionamenti fattivi che hanno come fine solo il bene comune. E non è che questi comportamenti sono solo di una comunità, dappertutto c’è chi bene o male ragiona così e, cosa più antipatica, chiunque batta sulla grancassa della protesta raccoglie sempre un discreto numero di sostenitori convinti che solo loro sono depositari di tutte le virtù e solo loro meritevoli di attenzioni e risorse.
Sgombriamo il campo da un equivoco di fondo, in tutti gli ambienti di lavoro (e la sanità non fa eccezione) c’è chi si impegna con entusiasmo e dedizione e altri che invece hanno una sensibilità molto spiccata verso i propri diritti e guardano con distacco e fastidio ai propri doveri. Entrambe queste categorie sono rappresentate in modo molto simile dappertutto e purtroppo non è l’appartenenza ad un campanile piuttosto che ad una altro che ci permette di separare i buoni dai cattivi; è vero che, talora, si possono instaurare particolari climi che permettono ad una concezione di prevalere sull’altra. Ma sempre anche in questo caso prima di potere emettere affrettate sentenze occorre essere certi di quello che si dice attraverso fatti e dati, occorre prendersi il disturbo insomma di esercitare un giudizio critico. Giudizio critico che ci permetterebbe di smascherare quei piccoli egoismi che talora vengono spacciati per bene comune.
La distribuzione delle risorse deve essere fatta secondo criteri oggettivi che tengano conto del bene comune, la recente esperienza ci ha insegnato che è necessario accorpare le specialità in modo da potere ottenere una sinergia di azione sui pazienti più complessi che necessitano di elevata intensità di cura. La recente esperienza ha dimostrato che per garantire a tutti la stessa opportunità di accesso alle cure si deve potenziare il territorio. Dove potenziare significa soprattutto integrare territorio e ospedale in modo che diventino da realtà contrapposte a un’unica modalità di cura che si continua nel tempo e nei modi per farsi carico di chi ha bisogno nei modi migliori e più facilmente fruibili.
Forse una soluzione sarebbe quella di passare da quattro ospedali distinti a un unico ospedale articolato su quattro sedi (la formula degli ospedali riuniti) che permetterebbe più agevolmente di distribuire le risorse sul territorio secondo le necessità del momento. Così come è avvenuto durante l’emergenza COVID. Si è concentrato ad Enna la cura dei pazienti infetti, e con le procedure corrette non si è diffuso il contagio nel territorio cittadino, demandando il non Covid ad altre sedi.
In questo particolare momento alla luce dei decreti che sono stati emanati ritengo sia possibile ritornare ai tavoli regionali per riprendere a trattare sulla sanità del nostro territorio cercando di ottenere una risposta adeguata ai nostri bisogni. Superando logiche ragioneristiche (peraltro male applicate) che hanno privato il nostro territorio di risorse importante a vantaggio delle aree metropolitane che invece concentrano servizi e strutture (anche nella sanità privata) a scapito del territorio della Sicilia Centrale; concentrazione stigmatizzata recentemente anche da una sentenza della corte dei conti.
Un meccanismo perverso che si chiama indice di fuga (ovvero il conteggio delle prestazioni erogate a utenti del nostro territorio che si fanno curare altrove) che alla fine dell’anno viene sottratto alle risorse destinate alla nostra ASP per essere destinato altrove (è inutile pagare strutture che non erogano prestazioni, meglio indirizzare le risorse nelle sedi preferite dagli utenti) accelera questo meccanismo di centralizzazione che contribuisce significativamente al processo di desertificazione della nostra provincia.
Quindi tornare alla normalità con i presupposti per migliorare e per fornire servizi migliori passa senz’altro attraverso una visione del bene comune superando i particolarismi di campanile che non hanno più ragione di essere e che anzi sul breve periodo se pervicacemente portati avanti ci costringeranno, per curarci, ad andare a Catania o a Caltanissetta.
Federico Amato Segretario Aziendale Cisl Medici di Enna